Lo stile egizio tra Impero e Art Decò
Fonte: Alessandra Doratti
Da un certo punto di vista si può dire che il revival egizio sia uno stile che dura da due millenni. Forse sarebbe più corretto dichiarare che l’Egitto non è mai morto nella consapevolezza critica dell’Occidente. I Romani consideravano l’Egitto la più grande delle loro conquiste e, nella scia della vittoria, Roma stessa si trasformò in un museo di antichità egizie, piccole e grandi.
Queste sopravvissero nel corso dei secoli, ispirando artisti quali Giovan Battista Piranesi. La moda di inserire nelle composizioni temi egizi, iniziata sul finire del Settecento, continuò per tutto il secolo successivo, il periodo appunto che molti storici identificano con il revival di questo stile. Usando le parole di James Stevens Curl, esperto d’arte, “l’Egitto ha continuato a esercitare sul gusto occidentale, un’influenza stranamente tenace e sorprendentemente duratura“.
L’Egitto è un motivo ricorrente nella nostra cultura: lo ritroviamo negli obelischi del Mall a Washinghton e di Central Park a New York, sulle banconote del dollaro, nei versi della Terra desolata e nelle pagine di Antiche sere di Norman Mailer, sul palcoscenico e sullo schermo in tutte le versioni possibili, da Shakesperare e Shaw, da Steve Martin a Mel Brooks. Il miracolo e la maestà delle piramidi affascinano il poeta e incantano l’ingegnere. È una cultura antica, misteriosa, esotica e, nello stesso tempo, accessibile e affascinante, vicina alla nostra sensibilità. A differenza di molte tradizioni non occidentali, l’Egitto appartiene al nostro patrimonio spirituale.
Dall’antica Grecia all’antica Roma, all’era cristiana: è questo l’itinerario della nostra storia; eppure l’Egitto in un modo che è difficile da definire, sembra precederla in forme che, pur profondamente diverse, sembrano affini. Atene, i Cesari, il Rinascimento sono momenti definiti nel tempo, mentre l’Egitto si sottrae alla cronologia, è questo preistorico, o per lo meno si attesta sul confine fra la “civiltà” e quanto veniva prima.
I semi di quella cultura, presenti nelle forme Art Déco e nel Flauto magico (decorato da Schinkel nel 1815 e da Hockney nel 1978), si riallacciano a un mondo che esisteva prima del tempo. I suoi obelischi e i monumenti che sorgono nel deserto discendono direttamente dalla misteriosa stele adorata dagli antropoidi nel film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Fino alla campagna di Napoleone nel 1798-99, l’Egitto esisteva nell’immaginario collettivo europeo soprattutto come una fantasia che affondava le radici nella cabala rinascimentale e nelle pratiche massoniche. Se ne conosceva l’arte attraverso i monumenti di Roma e delle province che Piranesi incorporò, dopo averli rielaborati, nel suo Diverse maniere del 1769, il più autorevole testo dedicato al mondo egizio. Piranesi amava di quell’arte l’austera semplicità in un’epoca che cominciava a volgersi al grandioso, al passionale, all’eterno: al sublime, in una parola.
Nell’aria vibravano i primi segni anticipatori del Romanticismo, sebbene non esistesse ancora tale definizione.
Nella sua opera, dedicata alla storia degli stili, Philippe Jullian ha definito l’Egitto “la Cina del Neoclassicismo“, intendendo che l’Egitto fu per gli artisti neoclassici importante come fonte di idee e di temi quanto lo era stata l’arte cinese per i predecessori del periodo Rococò. Ma possiamo ampliare l’antologia di Jullian: le caratteristiche dell’arte egizia ne fecero il tramite perfetto per conciliare gli aneliti romantici e l’importante gusto neoclassico. Era un’arte solenne, recondita, con una certa vena luttuosa – o per lo meno sobria – in sintonia con la sensibilità vittoriana. Dietro quelle forme si percepivano il peso dei millenni e la forza dell’ignoto. Nello stesso tempo erano rigorose, dirette, dotate di grande impatto visivo. Forse il grande revival egizio non ebbe inizio con la campagna di Napoleone, ma furono le sue conquiste, le scoperte che riuscirono a dare quello slancio che trasforma tendenze ed entusiasmi in autentici movimenti artistici.
Lo stesso Napoleone si fece promotore di una grande ricerca archeologica intitolata Descrizione, che sarebbe apparsa in venti volumi tra il 1809 e il 1828. Ma ancora prima era apparso il Voyage dans… Egypte del barone Dominique Vivant Denon, pubblicato a Parigi nel 1802 e stampato in inglese a Londra e a New York entro l’anno successivo.
Per la prima volta l’occidente contemplava l’arte egizia, le conseguenze furono elettrizzanti. I voli della fantasia si confrontarono con le scoperte archeologiche sulle quali insisteva lo spirito scientifico dei tempi: il sublime si misurava con il compasso. Ebbe così inizio un revival che, a due secoli di distanza, è ancora molto vitale, come hanno dimostrato le folle di tutto il mondo accorse alla mostra dedicata a Tutankamon.
In Inghilterra il grande paladino del movimento fu Thomas Hope, capace di coniugare la ricchezza inventiva con la precisione archeologica, in una sintesi che sarebbe stata imitata per tutto il secolo, soprattutto sessant’anni più tardi, da Christopher Dresser. I suoi mobili incorporavano molti principi strutturali degli originali egizi. La Francia e l’America cedettero alla moda l’una dopo l’altra. Venne a formarsi un vocabolario, adottato nel vecchio e nel nuovo mondo, in grado di descrivere le esigenze decorative e tutta una gamma di proporzioni. A Boston, come a Manchester, a Lione come a Mannheim proliferarono i temi ornamentali ispirati a quella antica cultura: mummie, sfingi e tripodi; l’intero pantheon delle divinità zoomorfe e antropomorfe, geroglifici e altri motivi scolpiti, dipinti, dorati, scanalati, da usare come supporti, rifiniture, decorazioni, a tutti i livelli di raffinatezza e sofisticazione, in tutte le gradazioni di utilità e sposa. Sofà, armadietti, librerie, sgabelli poggiapiedi, l’arredamento di un’intera casa.
Non mancarono alcuni eccessi dai tratti parodistici – non dimentichiamo che il revival egizio è alla radice delle infondate credenze sulla maledizione del faraone e la vendetta della mummia – ma nella maggioranza dei casi si trattava di oggetti dotati di grande fascinosa bellezza.
Oggi, a distanza di tempo dagli slanci filosofici e dagli entusiasmi archeologici, l’Egitto continua a incantarci, sono incomparabili la varietà e ricchezza dei motivi che l’artista può attingere da quelle forme, il carattere eterno di quel linguaggio che si sottrae alle leggi del tempo, eternamente “moderno” e utilizzabile oggi dal “gruppo di Neuf” come lo fu ieri da Frank Lloyd Wright o, ai suoi tempi, da Thomas Hope e dai suoi contemporanei o, ancora, dagli ebanisti americani della metà del secolo scorso.
Non è possibile attribuire limiti cronologici allo stile egizio: un gusto autenticamente cosmopolita, adatto a tutti i luoghi, in grado di assimilare i principi formali e le tendenze di ogni tempo, remote che non possiamo ignorare. E quello che non possiamo ignorare, siamo destinati a riproporlo nell’arte e nell’artigianato.
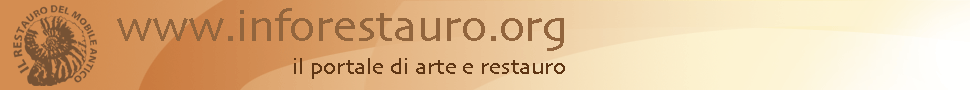









Pingback: COLONIALISMO INGLESE ED EGITTOMANIA di Francesca Pace | 360 Gradi