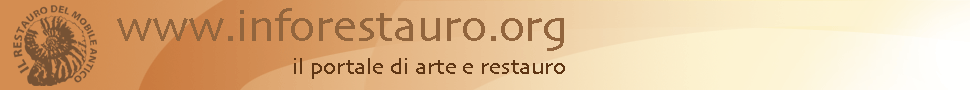La Finitura del Mobile
La finitura del mobile: storia, prodotti e metodi
La rifinitura del legno può essere effettuata mediante verniciatura o mediante pitturazione.
Per verniciatura s’ intende la stesura sulla superficie da trattare, di un prodotto trasparente, sia esso filmante o meno, colorato o meno. Per contro, la pitturazione è priva di trasparenza, e, quindi, sempre colorata. Si può paragonare la vernice all’acquarello, e la pittura alla tempera, tanto più bella quanto più trasparente la prima, tanto migliore quanto più coprente la seconda.
I trattamenti storici fondamentali, quelli cioè usati fino a tutto l’ottocento, sono a base di cere, di olioresine (dette anche vernici grasse) e vernici o pitture a solvente volatile, lacca povera (su fondo gessoso, colla animale pigmentata con terre, già in uso nel 300), biacca, lacca (molto in uso nel settecento), doratura nelle sue varie versioni e, infine, dalla prima metà dell’ottocento, gommalacca.
Cere naturali
Le cere naturali, la prima protezione, forse, ad essere stata usata, sono delle miscele intime di esteri acidi grassi a peso molecolare elevato e di alcoli superiori, di idrocarburi e di acidi grassi liberi ed alcoli liberi. Quando non sono raffinate contengono impurità organiche ed inorganiche di varia natura, sia di origine vegetale che animale, o anche minerale.
Le cere naturali si dividono in cere vegetali ed animali; accanto a queste due categorie si è soliti annoverare anche quella delle cere minerali, anche se chimicamente è impreciso definirle tali.
Ogni singolo componente delle cere ha un suo preciso punto di fusione, ma variando le proporzioni secondo la zona di produzione e, addirittura, del periodo dell’anno, il punto di fusione delle cere può variare notevolmente.
Cere vegetali
| Cera carnauba | |
| Peso specifico | 0,990-0.999 |
| Punto di fusione | 83°C – 86°C |
| Numero di saponificazione | 79-80 |
| Numero di iodio | 7-13 |
| Numero di acidità | 2-3 |
| Residuo insaponificabile | 54-55% |
| Ceneri | 0,43% |
E’ senza dubbio la cera vegetale più importante dal ‘500 in poi. Viene estratta da una palma tipica del Brasile (Copernicia baileyana Leon – Copernicia cerifera Mart.: Palma con tronco singolo, eretto, alto 10-12 m, coperto dai resti delle guaine fogliari. Le foglie, portate da un picciolo eretto, sono palmate, del diametro di 1,2-1,5 m, suddivise fino a metà in circa 60 segmenti fortemente appuntiti, di colore verde brillante e coperti da una sostanza cerosa. I fiori sono raccolti in infiorescenze a grappolo ramificate, lunghe quanto le foglie. I frutti, rotondeggianti, sono di colore brunastro. ndr).
Di colore bianco grigiastro, è la cera più dura e brillante, da una pellicola aderente ed elastica. Si scioglie in parecchi solventi, resiste bene all’umidità ed è difficilmente saponificabile. Contiene poca cera e molte sostanze caricanti quali stearina e paraffina.
| Cera ceroxylon | |
| Peso specifico | 1,020 |
| Punto di fusione | 92°C |
| Numero di saponificazione | 74-104 |
| Numero di iodio | 33 |
| Numero di acidità | 19,8 |
Originaria della Columbia e del Perù, ha colore giallo paglierino ed è costituita da una resina e da una cera. Per le sue caratteristiche è simile alla carnauba.
Si estrae da una palma del Madagascar. Il suo colore va dal bruno giallastro al bruno scuro. E’ dura, brillante e solubile a caldo negli usuali solventi. Molto usata prima della scoperta dell’America, ha poi ceduto il passo alla carnauba dotata di qualità superiori.
| Cera candelilla | |
| Peso specifico | 0,9825 |
| Punto di fusione | 68°C – 80°C |
| Numero di saponificazione | 65 |
| Numero di acidità | 12 |
| Numero di iodio | 37 |

Sotto questo nome si raggruppa una serie di cere con caratteristiche simili, estratte da varie specie di euforbiacee tipiche del Messico, della California e del Madagascar. Tali prodotti inizialmente hanno per lo più un colore grigiastro che diventa giallo chiaro dopo purificazione per ebollizione in acqua. La cera candelilla ha odore caratteristico, è meno dura, resistente e brillante della carnauba, resiste poco all’acqua e saponifica facilmente.
(queste piante “hanno sviluppato una tattica intelligente contro il caldo del loro habitat originario: i rami grigio-verdi, che crescono senza ramificazioni, così come le rare foglie, sono rivestiti da una cera dura, che protegge dall’evaporazione e dagli agenti atmosferici: la cera Candelilla.” ndr)
| Cera del Giappone | |
| Peso specifico | 0,875 – 0,990 |
| Punto di fusione | 58°C |
| Numero di saponificazione | 220 |
| Numero di iodio | 4,2 – 15,1 |
| Numero di acidità | 20 |
| Residuo insaponificabile | 1,15% |
| Ceneri | 0,02 – 0,08% |
Detta anche sego verde, si estrae da certi frutti in Giappone ed in Cina. Il suo colore è verdastro, ma, lasciata al sole, dopo qualche tempo tende al giallognolo. Essa veniva spesso falsificata con olio di perilla, e, a sua volta, serviva per adulterare la cera d’api. Saponifica con molta facilità, da pellicole brillanti ma collose.
Cere animali
| Cera d’api | |
| Peso specifico | 0,9961 -0,993 |
| Punto di fusione | 60°C – 71°C |
| Numero di saponificazione | 88 – 97 |
| Numero di iodio | 8 – 11 |
| Numero di acidità | 19 -21 |
| Residuo insaponificabile | 52 – 56% |
E’ senz’altro la cera più nota. Viene prodotta in un gran numero di paesi, e le sue caratteristiche variano entro limiti assai ampi secondo la zona di produzione e del periodo dell’anno. Spesso contiene grandi quantità di sostanze grasse. Il suo colore varia dal giallo paglierino al bruno, ma esposta al sole, tende a sbiancarsi ed a perdere il suo odore caratteristico. Si scioglie con facilità nei comuni solventi anche a freddo, da pellicole brillanti e resistenti.
| Cera cinese | |
| Peso specifico | 0,810 – 0,926 |
| Punto di fusione | 81°C – 83°C |
| Numero di saponificazione | 80 – 90 |
| Numero di acidità | 3 |
| Numero di iodio | 1,4 |
| Alcol | 49 – 51% |
| Acidi grassi | 51,5% |
| Residuo insaponificabile | 49 – 50% |
La cera cinese o cera di insetti ha colore bianco verdastro, è inodore e lucente, ha struttura cristallina ed è talmente dura da poter essere polverizzata. Veniva spesso usata come sostituto della cera carnauba.
| Cera di gommalacca |
|
Tale cera viene estratta dalla gommalacca nella quale è presente in una quantità del 5 – 6%. Di colore giallastro, è dura e brillante. Fonde fra i 52 e gli 80°C. |
Cere minerali
| Cera montana | |
| Peso specifico | 1 |
| Numero di saponificazione | 74 – 107 |
| Punto di fusione | 76°C – 90°C |
| Numero di acidità | 70 – 80 |
| Numero di iodio | 10 – 20 |
| Residuo insaponificabile | 50% |
Si estrae da ligniti bitumose (viene anche chiamata cera di lignite); di colore bruno scuro, è formata da miscele di acidi grassi, di alcoli, da una resina e da un poco di bitume. Si raffina con difficoltà, e quando è purificata è di colore bianco. Si polverizza con facilità e genera una pellicola brillante e resistente.
| Cera ozocherite |
|
Si estrae dai residui della distillazione del petrolio; di colore bianco, ha struttura microcristallina, si miscela facilmente con tutte le cere ed i solventi, fonde a 72 – 77°C e, come la paraffina, è costituita da miscele di idrocarburi. Si trova anche da sola allo stato naturale in zone delle Russia e della Polonia. |
| Paraffina |
|
La paraffina, come l’ozocherite, non ha affatto la costituzione delle cere, ma viene classificata come tale benché sia costituita da idrocarburi ad elevato peso molecolare. Si trova in commercio in svariate versioni con punto di fusione oscillante da 30 a 110°C. Di colore bianco e struttura cristallina, si lega con difficoltà alle altre cere e da pellicole poco brillanti, scarsamente resistenti e tenere. |
| Ceresina |
|
Si tratta di miscele di ozocheriti e paraffine, o di paraffine e cera carnauba in varie proporzioni e, quindi, con svariate caratteristiche chimico-fisiche. |
Raramente le cere venivano usate singolarmente. Il più delle volte si faceva ricorso a miscele per accentuare certe caratteristiche secondo l’ applicazione specifica. Va da sé che l’inceratura di un portone esposto alle intemperie doveva avere caratteristiche ben diverse da quella di un mobile di pregio, o di un mobile rustico. Nel primo caso, per esempio, si arricchiva la cera d’ api con carnauba (questo connubio è stato molto usato a partire dal 600) e con cera montana, aggiungendo al tutto una resina, mentre per il mobile di pregio conveniva usare cera d api, e per quello rustico si ricorreva magari alla ceresina. Bisogna tener presente che la miscelazione delle varie cere ha dato luogo ad un numero pressoché infinito di composti che il più delle volte venivano realizzati artigianalmente e le cui formule erano tenute segrete. La storia ci ha tramandato, a questo proposito, episodi eclatanti come, per esempio, quello di Stradivari che morì senza rivelare i segreti delle sue vernici nemmeno al figlio.
La preparazione delle cere ha sempre rappresentato un operazione lunga e di un certo pericolo dovuto al dover sciogliere la materia prima a caldo col conseguente pericolo di incendi. Al momento le ditte produttrici di materiali destinati al restauro possono fornire una gamma completa di cere che va da quelle più povere e rustiche a quelle più fini, a cere dotate di ottima idrorepellenza, quelle da stendere a tampone, dall’effetto estremamente lucido, alle cere da riempimento … garantendo una qualità costante che la preparazione artigianale non permette.
A proposito delle cere da usare a stoppino, mi capita spesso di vedere (ed anche di leggere su capitolati redatti da sovrintendenze) mobili di fabbricazione anteriore all’ottocento trattati a stoppino con gommalacca. Si tratta di un anacronismo imperdonabile. Forse è il caso di dedicare poche righe all’ argomento gommalacca , dal momento che in proposito si sono ingenerate tante confusioni.
La Gommalacca …. una questione ancora aperta
La gommalacca è una resina organica secreta da un insetto della famiglia delle Cocciniglie, la Tacardia Lacca, parassita di varietà di piante del subcontinente indiano. Questo insetto produce una sostanza resinosa che costituisce una sorta di scudo protettivo di colore rosso scuro, chiamata lac (termine di origine sanscrita). Alla fine del ciclo vitale di tali insetti, questa crosta viene raschiata via, lavata, asciugata all’ombra, raffinata per eliminare i rimasugli degli insetti stessi. E interessante notare come questo insetto produca contemporaneamente materie resinose, cerose, albuminose, zucchero, una materia colorante solubile nell’acqua ed una solubile in alcol. Originariamente la lavorazione della gommalacca era finalizzata esclusivamente all’estrazione del pigmento rosso che le conferisce la tipica colorazione. Il suo uso in tal senso è citato da Claudius Aelianus (170-235 d.C.) nel suo Sulla natura degli animali; si suppone, comunque che tale tintura fosse conosciuta dai Greci da almeno cinque secoli prima. Venne poi riscoperta dagli Inglesi nel 1790. Col nome lac dye , mescolata col carminio, altro pigmento estratto da un’altra cocciniglia, veniva usata per tingere l’abbigliamente delle Giubbe rosse . In Italia tale colorante, molto costoso, veniva commercializzato col nome di lacca rossa, e fu molto ricercato fino a metà ottocento, quando fu soppiantata dall’anilina decisamente meno costosa.
In un opera del 1590, uno scrittore inglese relazionando un viaggio in India, parla di come nella fabbricazione di suppellettili lignee al tornio, la gommalacca venisse usata come vernice di rifinitura sfruttandone le qualità termoplastiche, strusciandone, cioè, un blocco sull’oggetto in movimento sul tornio. Essa veniva sciolta dal calore provocato dall’attrito penetrando nelle fibre del legno. Successivamente veniva lisciata e lucidata mediante paglia o altre fibre vegetali.
E presumibile che in Europa vi fossero sporadici arrivi di tale resina, ma non se ne hanno notizie certe. Si dice, per esempio, che uno dei segreti del già citato Stradivari fosse, appunto, l’utilizzo della gommalacca nella realizzazione delle sue vernici. Quello che è certo è che la sua commercializzazione su larga scala la si ebbe soltanto durante la prima metà dell’ottocento ed il suo uso divenne sempre più massiccio fino al 1930, quando fu soppiantata dalle prime nitrocellulose.
Risalgono a questo periodo, nel quale il legno incomincia ad essere lavorato con sistemi industriali, certe cattive abitudini che persistono nelle nostre botteghe di restauro. Nella quasi totalità degli interventi, si procede sistematicamente ad una totale sverniciatura e riverniciatura dell’ Oggetto. Questa metodologia di intervento semplifica notevolmente il procedimento concettuale e, a volte, quello tecnico, ma, nella sua rozzezza, non sempre perviene a buoni risultati. Il procedimento di inceratura che viene usato ormai come consuetudine si può riassumere in questi termini (tralasceremo per ora le incerature ad encausto):
colorazione con rolla diluita in acqua o con anilina in solvente alcol, o con pigmenti di ultima generazione;
fondo con gommalacca stesa a pennello;
pagliettatura leggera;
inceratura.
Patinatura del legno
Tralasciamo ora l’ argomento sverniciatura, già trattato in un precedente capitolo, e soffermiamoci sulla colorazione e rifinitura. Anticamente il legno veniva tonalizzato in due modi: con una soluzione acquosa pigmentata dal mallo delle noci (la cosiddetta rolla è figlia di tale colorante), o con terre sciolte in soluzioni oleose od olioresinose. Spesso queste ultime vernici erano usate come fondo per la cera, soprattutto nel trattamento di legni dolci e, quindi, caratterizzati da un forte potere assorbente. Purtroppo attualmente viene fatto un grande uso di aniline o, peggio, dei moderni pigmenti a base di ossidi in soluzione solvente. Questi ultimi, a parte la loro opacità e, quindi, i risultati scadenti a livello estetico, non resistono ai raggi ultravioletti e si deteriorano molto velocemente; le aniline, il più delle volte sono anacronistiche essendo state sintetizzate da Hofman intorno al 1850. La loro trasparenza si adatta più alle verniciature con gommalacca che con quelle a cera.
Legno antico e moderno
Occorre tener presente la grande differenza che intercorre fra i legni antichi e quelli moderni, e i differenti modi di lavorazione. Innanzitutto l’albero veniva abbattuto in un periodo di luna calante per evitare precoci aggressioni di tarli, ed immediatamente tagliato in tavole che venivano fatte invecchiare all’aperto, accatastate e girate due volte l’anno. Questa stagionatura durava almeno cinque anni, ma spesso tale periodo era molto più lungo. Ancora oggi, in certe campagne, è sopravissuta la tradizione di conservare il legname abbattuto alla nascita di un figlio per l’utilizzo in occasione del suo matrimonio.
Attualmente gli alberi vengono abbattuti con criteri industriali, solitamente in luoghi molto distanti da quello di lavorazione; quindi, dal momento dell’abbattimento a quello della lavorazione intercorre parecchio tempo, con conseguenti aggressioni fungine. Dopo la riduzione in tavole, il legno viene essiccato in forno. Questa metodologia che elimina la stagionatura, porta ad un impoverimento delle fibre che non hanno modo di sviluppare quelle trasformazioni chimico-fisiche che permetterebbero al legno di acquisire tutte quelle caratteristiche positive che lo hanno sempre caratterizzato. Il legno diventa arido, poroso, acquisisce grande igroscopicità, perde le difese nei confronti dei parassiti sia animali che vegetali. Per tale motivo viene immediatamente trattato con biocidi quali bromuro di etile o formaldeide in camere a gas. Nonostante una caratteristica peculiare di tali prodotti tossici sia la notevole persistenza (che fa sì che vengano rilasciati gradatamente nell’ambiente a scapito della nostra salute), essi, in particolari condizioni, non riescono a proteggere in modo assoluto il legno.
Un altra grande diversità è data dalla differente lavorazione che comporta il legno così trattato. Ci soffermeremo soltanto sulla carteggiatura, che è quasi indispensabile nella rifinitura dei legni moderni e che nelle botteghe di restauro viene effettuata in più riprese, alternata a bagnature con acqua per “sollevare il pelo”, operazione atta ad eliminare i frammenti mobili di fibre rotte dalla carteggiatura stessa. Fino alla prima metà dell’ottocento il legno non veniva carteggiato, ma levigato. A tale scopo venivano usate pinne di squalo o, più spesso, rasiere. La rasiera è un attrezzo costituito da una lastra metallica rettangolare che viene affilata in modo particolare. Anzitutto deve essere arrotata come una qualunque lama, dopodiché il filo viene piegato ad uncino in modo che, passata sul legno in posizione quasi verticale ad esso, ne asporta un sottilissimo strato spianandolo e levigandolo. La leggera ondulazione tipica dei legni antichi è data in parte dal differente ritiro delle fibre della lignina, ma anche dalla rasieratura. Tale operazione non rompe le fibre, ma le taglia, e conferisce al legno una superficie tale da risultare protettiva e dotata di una considerevole idrorepellenza.
E facile, a questo punto, capire come un legno così trattato difficilmente abbia bisogno di un fondo atto a supportare il trattamento ceroso, a meno che non si tratti di un legno per sua natura particolarmente assorbente e poroso.
Dopo la carteggiatura il legno, trovandosi in una situazione di poro aperto, deve essere trattato con qualcosa che crei una superficie poco assorbente e atta a supportare la cera. La moderna industria ha creato a questo scopo appositi turapori, le caratteristiche dei quali sono sotto tutti gli aspetti, pessimi. Per tale motivo non è il caso di analizzarli in questa sede. Nell’ambito del restauro, semplicemente, non vanno usati, anche se in passato effettivamente a volte sono stati utilizzati dei fondi che, comunque, avevano delle caratteristiche ben diverse dai moderni turapori, non essendo filmanti ed essendo dotati di totale trasparenza e capacità totalizzante.
Di solito si trattava di oli addizionati con resine che avevano lo scopo di conferire all’olio maggiore durevolezza e resistenza. Non è facile risalire a formulati esatti, poiché le fonti storiche il più delle volte sono imprecise o vaghe, o ambigue nella terminologia, nella descrizione delle modalità operative, nelle ricette improntate di empirismo o legate a segreti di bottega.
Una vernice che risulta essere stata molto usata con una serie di varianti era detta Megylp. Nata e fabbricata in Olanda, usata come protettivo in pittura, era costituita da una miscela di trementina e mastice addizionata con oleoresine (elemi e trementina veneta) ed olio di lino. Con l’aggiunta di cera d api sbiancata, si otteneva un ottimo prodotto di fondo per la rifinitura a cera.
Attualmente, come già accennato, è invalsa la pessima abitudine di usare sistematicamente come fondo, gommalacca data a pennello, seguita da una leggera pagliettatura atta ad eliminare le inevitabili imperfezioni. Questa resina, se stesa con la tecnica dello stoppino, possiede ottime qualità di trasparenza e di idrorepellenza che perde totalmente se stesa a pennello, acquistando porosità e fragilità. Basta una goccia d acqua per assistere ad uno sbiancamento del legno, basta lo sfregamento di un unghia per creare righe vistose. Nonostante ciò questa pratica è diffusissima; evidentemente, e spesso a torto, l’artigiano restauratore è convinto che operando in tal modo possa risparmiare tempo e materiale.
E auspicabile che anche nelle più modeste botteghe di restauro si impari ad essere più rispettosi delle vecchie vernici e delle cere che non sempre occorre eliminare con la violenza e la drasticità di una sverniciatura. Spesso basterebbe una pulizia con acquaragia atta ad eliminare soltanto la sporcizia lasciando inalterata la superficie con il trattamento originale che il più delle volte è tuttora valido, o, eventualmente, abbisogna soltanto di essere ravvivato con una leggera olioresina, o con una olioresina mescolata con cera.
Spesso l’ inceratura veniva effettuata con la tecnica dell’encausto. Tale sistema, che consisteva nell’usare la cera allo stato liquido per fusione a caldo (il termine deriva dall’encausto latino che veniva effettuato con cera punica). In tal modo l’effetto impregnante della cera veniva potenziato tanto da poter rinunciare a vernici di fondo anche su legni molto teneri e porosi.
A questo punto risulta chiaro come il confine fra cere ed olioresine spesso fosse molto sfumato, e come spesso sia difficile, se non impossibile risalire con precisione ai prodotti originali, anche eseguendo analisi chimiche molto complesse.
Le vernici grasse sono costituite fondamentalmente da uno o più oli che possono essere addizionati a resine, con l’aggiunta di un diluente.
Gli oli usati nella preparazione di vernici devono essere siccativi, devono, cioè, avere la proprietà, quando siano stesi in strato sottile su di un supporto, di dar luogo ad un film duro, lucido e resistente. Essi vengono estratti da semi tramite spremitura o estrazione con solventi.
Il numero di questi oli, che in passato era assai limitato, è andato sempre più allargandosi, per arrivare nell’800, secolo del loro massimo uso, ad una cinquantina. Quelli più usati nella preparazione delle vernici nell’antichità sono: l’ olio di lino, di colza, di legno, di oiticica, di perilla, di ricino, di soia, di vinaccioli. Per esaltarne le qualità siccative, questi oli vengono sottoposti a cottura (generalmente dai 250° ai 300°), e spesso anche a soffiatura. Tale processo consiste in una ulteriore cottura ad una temperatura più bassa in presenza di ossigeno, ed ha il risultato di conferire all’olio un maggiore ispessimento.
Gli oli siccativi, se usati da soli, raramente danno luogo ad una pellicola sufficientemente resistente. Occorre, dunque, quasi sempre incorporare ad essi una o più resine.
Le resine naturali sono generalmente poco solubili negli oli; è necessario, quindi, sottoporle ad operazioni che ne rendano possibile la messa in soluzione.
La pirogenazione, operazione che consiste nel portare la resina ad una temperatura superiore al suo punto di fusione, ha appunto questo scopo. Oltre a tale operazione, per rendere maggiormente essiccativa la vernice ottenuta, occorre aggiungere a caldo ossidi o sali metallici. L ultima operazione nella preparazione delle oleoresine è la tonalizzazione, se necessaria. Essa si ottiene mediante l’aggiunta di terre. Tali sommarie indicazioni possono essere utili qualora occorra modificare alcune caratteristiche delle oleoresine reperibili sul mercato, tantopiù che i fabbricanti raramente sono disponibili a collaborazioni in tal senso, sia perché possono rappresentare una perdita di tempo priva di tornaconto, sia per l’esigenza, più o meno reale, di salvaguardare segreti di fabbricazione.
Olioresine
Le olioresine possono essere usate in varie modalità: a tampone (è molto diffusa la credenza che la verniciatura a tampone sia stata inventata dagli ebanisti francesi ed usata esclusivamente per la stesura della gommalacca; si tratta di una credenza errata, poiché questo metodo di verniciatura era in uso in tutta l’Europa da tempo immemorabile, applicato sia per le olioresine, sia per certe cere), a pennello, mediante spugnatura o spruzzate con irroratori da giardino (non con spruzzatori da carrozziere, poiché con essi si ottiene una nebulizzazione eccessiva), di solito in due o più riprese a seconda del prodotto e del legno che deve accoglierle. Se il supporto ligneo è poco assorbente sarà bene che la prima mano venga diluita, così da aumentarne la penetrazione. Poiché questi prodotti agiscono per penetrazione, essi vanno dati in abbondanza. La superficie lignea, non essendo compatta, assorbirà il prodotto in modo non uniforme. Non appena l’assorbimento avrà subito un rallentamento, bisognerà intervenire con una pennellessa pulita o con uno straccio per spargere il prodotto eccedente. E della massima importanza evitare che eccessi di vernicie tendano ad essiccare sulla superficie, poiché si formerebbero filmature non traspiranti e poco resistenti, poiché vi è una tendenza alla pellicolazione di superficie che impedisce la completa polimerizzazione del prodotto sottostante. In linea di massima queste vernici, se usate correttamente, raggiungono una essiccazione al tatto entro quattro ore, ed una essicazione completa entro quarantotto.
A seconda della porosità del legno, occorrerà ripetere tale operazione più volte, sino a quando l’assorbimento sarà nullo. In questo modo si sarà ottenuta una superficie serica al tatto e morbida alla vista, idrorepellente e traspirante. Se in seguito tali superfici subiranno abrasioni o rigature, basterà agire con un batuffolo di cotone intriso del prodotto iniziale per cancellare tali alterazioni cromatiche. Le ditte produttrici, di solito, prevedono una ulteriore protezione cerosa realizzata con emulsione resinocerosa (anche in questo caso la resina ha il senso di conferire al prodotto quella resistenza che le cere non possiedono). Come per tutti i prodotti finiti, anche per questi il fabbricante tende a fornire schede tecniche incomplete e nebulose, così che l’operatore il più delle volte si trova ad usare prodotti dei quali sa molto poco. Non bisogna aver timore nel contattare gli uffici tecnici delle varie ditte per avere informazioni più dettagliate sulla composizione dei prodotti, i loro pregi e difetti, le modalità di utilizzo ecc. Occorre, per esempio, accertarsi che la pigmentazione sia stata effettuata con terre anziché con ossidi, poiché questi ultimi, sensibili ai raggi ultravioletti, tendono a deteriorarsi molto velocemente. Se si nutrono dubbi in proposito, è consigliabile totalizzare personalmente l’olioresina neutra e, nel caso di tonalizzazioni accentuate, se il prodotto tende ad opacizzarsi, aggiungere un pò di propoli (che è compatibile con quasi tutte le oleoresine) per ridare trasparenza, oltretutto la propoli è un potente biocida, e ciò non guasta.
Con un po di pratica e di esperienza, è possibile ottenere da questi prodotti molto di più di ciò che ci si aspetta da una normale vernice.
Nel caso si dovesse intervenire su travature o soffittature, l’operazione sarà altrettanto semplice e veloce, poiché tali manufatti di solito sono molto assorbenti e richiedono soltanto due o tre passate a spruzzo, senza dover eliminare le eventuali eccedenze che tendono a sgocciolare.
Una categoria di vernici che è stata usata nell’antichità è quella delle vernici a solvente volatile.
Si tratta vernici ottenute sciogliendo una o più resine naturali in uno o più diluenti o solventi.
Le resine naturali sono sostanze di origine vegetale, fossile o, come nel caso della gommalacca, animale. Quelle vegetali sono ottenute generalmente tramite incisione da un certo numero di piante; all’aria si condensano in masse di colore giallastro o brunastro, più o meno dure. Quelle fossili, come l’ambra e le coppali di Zanzibar, del Monzambico, dell’Angola, di Loango, di Benguela vengono pescate dal mare o rinvenute sul terreno, o a qualche metro di profondità in pezzi di varia dimensione. Esse sono inizialmente formate da un olio essenziale più o meno volatile e da un corpo fisso: la resina vera e propria. Il composto volatile è di natura terpenica. La natura chimica della resina varia a seconda della provenienza e dell’epoca di raccolta. Capita addirittura che lo stesso albero fornisca resine di composizione assai diverse a seconda del clima nel quale vive.
La proprietà fondamentale delle resine nell’impiego nelle pitture e nelle vernici è la durezza, che varia molto a seconda del tipo. Altre caratteristiche importanti sono la trasparenza ed il colore.
Sotto il nome di coppali (o copali) vanno una serie di importanti resine quali, dalle più dure, le Zanzibar, le Monzambico e le Madagascar; meno dure sono le Angola, le Sierra Leone, le Benguela, le Congo e le Kauri; più tenere sono le Manilla, le coppali del Borneo, della Guyana e della Cocincina. Fra le altre resine la più dura è la damar, seguita dalla gommalacca, la mastice, la sandracca, la colofonia, l’elemi e la pece di Borgogna.
Le resine importanti nel campo del restauro si riducono ad una ristretta cerchia.
La TREMENTINA
è propriamente una oleoresina. Essa scola da screpolature naturali della corteccia, o da incisioni praticate dall’uomo, di varie specie di conifere. In passato le trementine venivano classificate in due grandi categorie: le comuni o di pino e le trementine fini o balsami, estratte dal larice. Le più conosciute sono quella Veneta, di Strasburgo, di Bordeaux, di Jura e di Chio anticamente detta Therebinthos.
La trementina è una materia resinosa, attaccaticcia, giallastra, dal caratteristico odore e dal sapore amaro, acido e contemporaneamente aromatico. Viene usata per solubilizzare la maggior parte delle resine terpeniche, gli oli ed i sali metallici impiegati come siccativi. Da essa si estraggono l’acquaragia o essenza di trementina e la colofonia.
La COLOFONIA
è il residuo secco della distillazione della trementina. Si tratta di una resina vetrosa, semitrasparente, fragile e friabile; il suo colore può andare dal giallo chiaro al nerastro.
A livello commerciale le varie qualità venivano catalogate in una rigida classificazione basata fondamentalmente sul colore, partendo da quelle più chiare, per arrivare a quelle più scure che in Francia andavano sotto il nome di brais. Le colofonie erano senz altro le resine più economiche e le più usate, benché dessero luogo a vernici di scarso pregio per la loro eccessiva fragilità e breve durabilità. Tali caratteristiche sono dovute sia alla sua eccessiva acidità, sia al suo basso punto di fusione.
La MASTICE,
ottenuta per essudazione dalla pistachia lentiscus. Veniva prodotta nell’arcipelago greco, in Portogallo, in Marocco e nelle Canarie; la più nota era quella dell’isola di Chio.
Questa resina, che è stata molto usata come protettivo e legante in pittura, è solubile in etere, cloroformio, tetracloruro di carbonio, amil acetato, essenza di trementina, idrocarburi aromatici; è completamente insolubile in wite spirit. I films a base di mastice sono elastici, ma di durata limitata, sono sensibili ai raggi ultravioletti, per cui tendono col tempo ad ingiallire ed a diventare fragili. Per questi motivi veniva spesso utilizzata in soluzione con olio di lino, trementina e altre oleoresine, come nel Megilp del quale si è già parlato.
La ELEMI:
sotto tale denominazione venivano annoverate resine di varia provenienza, spesso dotate di caratteristiche molto diverse. In linea di massima si trattava di resine dalla consistenza simile al miele e colore che poteva andare dal grigiastro, al verde, al giallognolo. Essendo dotate di ottima resistenza all’umidità ed alle basse temperature, sono state molto usate nel nord Europa come protettivi e come plastificanti.
Mescolando la elemi con cera d api, si ottiene una pasta consistente e plastica che in passato veniva usata per stuccature su legno e veniva chiamata cera resina.
La DAMMARA (o DAMAR dalla lingua malese),
detta anche resina del Kauri, viene estratta da piante sia fossili che viventi nelle isole Malacche, a Sumatra e in Indonesia. Sotto tale denominazione andava anche una resina proveniente dall’Australia. Solubile in un miscuglio di alcol etilico ed etere, tende ad ingiallire col tempo. Veniva mescolata alle cere per encausto.
Come si può notare le resine non sono mai state classificate in modo preciso, né tantomeno con criteri chimico-fisici, ma, tuttalpiù, seguendo criteri commerciali o di utilizzo pratico. La ricerca su vecchi testi porta spesso all’acquisizione di notizie contraddittorie.
La GOMMALACCA
è di origine animale. Essa viene ricavata da un piccolo insetto della famiglia delle coccidee parassita di piante del genere ficus indica, ficus religiosa ecc., la cui linfa fornisce all’insetto il nutrimento necessario alla produzione di un guscio protettivo di lacca. E interessante notare come quest’insetto produca contemporaneamente materie resinose, coroidi, albuminoidi, zucchero, una materia colorante solubile in acqua ed una solubile nell’alcol. Allorquando gli insetti hanno concluso il loro ciclo vitale, le incrostazioni di lacca vengono raschiate e raccolte, vengono fuse, lavate, seccate ed, infine, filtrate a caldo. I residui della filtrazione (kiri), opportunamente trattati con solventi, possono dare una gommalacca scadente, di colore molto più scuro.
Sovente la gommalacca veniva mescolata con colofonia o con orpimento (altrimenti detto giallo reale o giallo del re: solfuro di arsenico) per ravvivarne i riflessi giallo dorati. La gommalacca è solubile in alcol e negli alcali, da films dotati di grande adesione, brillantezza, elasticità ed idrorepellenza (se stesa a stoppino). Le sue proprietà termoplastiche venivano sfruttate dagli ebanisti per eseguire piccole stuccature prima della verniciatura. Queste qualità, unite ad una relativa facilità d uso ed al suo costo molto contenuto, ne hanno fatto per tutto l’ottocento la resina per eccellenza nella verniciatura di mobili eleganti, soprattutto intarsiati ed impiallacciati.
Abbiamo visto come le resine servissero alla realizzazione sia di vernici che di pitture, le quali venivano usate soprattutto per la protezione di infissi e strutture edili povere; molto raramente per mobili che, se dovevano essere pitturati, lo erano piuttosto con tempere più o meno forti, a volte direttamente sul legno, a volte su un fondo gessoso, oppure con biacca.
La BIACCA (carbonato basico di piombo)
è il colore bianco più usato nell’antichità. Non se ne conosce l’origine, poiché è presente in tutte le civiltà note. Le descrizioni dei metodi di fabbricazione riportate da varie fonti quali Plinio, Teofrasto, Dioscoride, concordano alla perfezione con quelle orientali (enciclopedia giapponese). Nel medio evo la produzione della biacca era detenuta dagli Olandesi, dai Genovesi, dai Veneziani e dai Pisani. Nel 1200 Pisa e Genova la fabbricavano nell’Africa orientale per poi importarla in Italia.
La fabbricazione della biacca, che nell’ottocento subì notevoli trasformazioni a causa dell’industrializzazione, veniva effettuato con un processo che nel medio evo era chiamato “olandese”. Consisteva nel far agire sul piombo metallico l’azione simultanea dei vapori di acido acetico, dell’ossigeno dell’aria e dell’acido carbonico. Il metallo veniva fuso in caldaie di ghisa e colato in lamine sottili di 40 – 50 cm. per 10 – 12, dello spessore di cm. 0,05. Questi fogli venivano ottenuti versando una cucchiaiata di piombo fuso in una forma di ferro che ha l’aspetto di una cassetta con i bordi pochissimo rilevati, posta in modo da essere leggermente inclinata. La lamina così ottenuta si raffreddava in pochi istanti e poteva essere prelevata con apposite pinze ed accatastata con le altre. Questo insalubre lavoro veniva dato a cottimo ad operai molto esperti che lo eseguivano con abilità e rapidità sorprendenti. I fogli così ottenuti venivano avvolti a spirale in modo che le superfici delle facce non si toccassero, e posti in vasi di terracotta il cui interno, verniciato, portava a circa un terzo della loro altezza un piccolo rialzo a treppiedi che serviva a sostenere le spirali stesse. Nel fondo di tali vasi veniva versato dell’acido acetici di qualità scadente, oppure dell’aceto mescolato a lievito di birra che ne accentua la fermentazione. I vasi così preparati venivano accatastati in enormi buche, profonde 7 o 8 metri, scavate nella terra e rivestite di muratura, alternati a strati di letame equino fresco, ritagli di piombo scartati nella fusione e ricoperti da tavole di legno, così da formare un pavimento sul quale piazzare un altro strato come il precedente, sino a riempimento della buche stesse. Si calcola che una fossa lunga m.5, larga 3,5 e alta m.7, potesse contenere da 6 a 8000 vasi della capacità di 1000 cm. cubi, per un totale da 9 a 11000 kg. di piombo. A questo punto aveva inizio il processo di fermentazione del letame con lo sviluppo di CO2 e di calore (che non doveva superare i 100°, altrimenti la biacca si sarebbe decomposta con la conseguente formazione di minio) che veniva tenuto sotto controllo mediante la circolazione dell’aria all’interno delle buche stesse. L aumento della temperatura provocava l’evaporazione dell’acido acetico che in presenza dell’aria circolante tra un vaso e l’altro e dell’acqua, convertiva il piombo in acetato basico di piombo, che veniva poi trasformato in carbonato calla presenza del CO2 sviluppato dal letame.
La durata di questo processo era di circa cinque settimane. E evidente come occorressero tante buche per poter avere continuità di lavorazione. Durante questo processo, la maggior parte del piombo si era trasformato in biacca che si presentava come una crosta dura aderente ai residui delle lastre; occorreva, quindi, sottoporre le lastre stesse alla “battitura” che consisteva nello staccare la biacca dai residui mediante mazzette di legno. Tale operazione era la più pericolosa di tutto questo processo, poiché provocava lo sprigionarsi di una finissima polvere che veniva respirata dagli operai provocando un lento avvelenamento. E soltanto verso la metà dell’ottocento, con l’avvento dell’industrializzazione, che tale lavorazione è diventata meno pericolosa. Nonostante ciò, risulta che soltanto nel triennio 1910 – 1912 i ricoveri per saturnismo in Italia siano stati 445. Attualmente l’uso della biacca e delle pitture contenenti piombo è regolato dalla legge n. 706 del 19 luglio 1961, che ne limita drasticamente l’uso.
La biacca è una polvere bianca amorfa, pesante, senza odore né sapore. Dal punto di vista del suo impiego in pittura è sempre stata considerata come il pigmento bianco che da i migliori risultati. Essa è facilmente mescolabile e miscelabile con olio di lino, del quale aumenta il potere essiccativo.
Mescolata con terre da colori morbidi e pastosi. Sul legno veniva stesa direttamente sulla sua superficie o, per ottenere laccature più fini, su un fondo gessoso. Col tempo tende a cavillare. Tale caratteristica ne aumenta la durata, poiché permette una traspirazione ottimale.
Le biacche deteriorate possono essere facilmente ripristinate con ritocchi con colori ad olio, e protette con un sottile velo di cera.
Bisogna prestare particolare attenzione al fatto che molto spesso la pitturazione a biacca veniva effettuata in un periodo successivo alla fabbricazione del manufatto, in sostituzione di un inceratura deterioratasi troppo velocemente, o per adeguare l’estetica alla mutazione del gusto. In tal caso si impone la scelta di conservare o meno una pitturazione non coeve all’oggetto. Ovviamente la decisione sarà condizionata dalla filosofia del restauro adottata dall’operatore o dalla DL. E dallo stato di conservazione della biacca stessa.
Conclusioni
In conclusione, l’operatore si trova a muoversi contemporaneamente su due piani: la filosofia del restauro e la tecnica che ne consegue. Un moderno restauro, anche se eseguito su manufatti che non possono essere definiti “opere d arte”, deve seguire rigide regole di rispetto verso Oggetti che sono testimonianze uniche ed irripetibili del nostro passato, della vita dei nostri padri, della nostra storia e, quindi, della nostra cultura. E indispensabile tener sempre presente che qualunque alterazione che venga apportata dal restauratore, è storicamente una falsificazione, e le uniche falsificazioni accettabili sono quelle tese alla conservazione del Bene, cioè, quelle funzionali. Per oggetti che sono destinati anche ad un uso pratico, seguire rigidamente questa regola non è sempre possibile, ma è pur sempre possibile ridurre i compromessi al minimo.