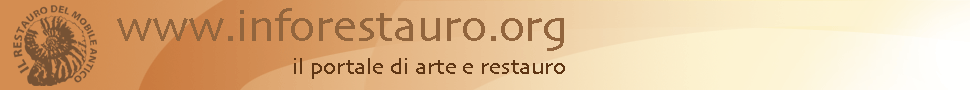Il Manierismo, ovvero l’arte di imitare
Manierismo è un termine, derivato dal Vasari, il quale nella terza parte delle “Vite” usò espressioni come: “maniera secca“, “gran maniera“, per indicare lo “stile” grazie al quale Michelangelo, Raffaello, Correggio e Tiziano riuscivano a “ritrarre le cose più belle
Fonte: Alessandra Doratti
Tra le accuse che vengono mosse da studiosi e artisti italiani e stranieri ai restauratori degli affreschi michelangioleschi della Cappella Sistina, c’è quello di “ridurre” il grande genio toscano a pittore manierista: accusa o limitazione certo non nuova, se già gli eruditi Giovanni Gaetano Bottari (1689–1775) e Luigi Lanzi (1732–1810) insinuavano che in lui “vi è un poco dell’ammanierato, coperto con tale arte che non si vede“.
Il che significa che Michelangelo era bravissimo anche nel nascondere i suoi eventuali difetti. Ma l’origine delle attuali polemiche deriva più che altro dal trovarsi davanti degli affreschi esaltati per secoli come “drammaticamente” scultorei (grazie anche al fumo delle candele e alle colle dei vecchi restauratori, che li avevano scuriti), e diventati invece di colpo vivacissimi per i verdi, i rossi, i viola, gli arancioni, ora delicati ora forti, che prima, appunto, non si vedevano.
Se, insomma, quando alla fine dell’ottobre 1512, coloro che videro per primi la volta della Sistina rimasero “mutoli“, e il 1 novembre 1541 davanti al “Giudizio Universale” restarono sgomenti, oggi chi può osservare le parti restaurate in circa sei anni di lavoro, si trova perlomeno perplesso: quasi credendo, lì per lì, quei dipinti rimessi a nuovo non già di Michelangelo, ma di un Jacopo da Pontormo o di Rosso Fiorentino, che del Manierismo furono tra i protagonisti migliori.
E’ già evidente da questi accenni che “Manierismo” venne e viene usato in senso limitativo, se non proprio spregiativo: per indicare cioè il lavoro di quegli artisti che, nel 500 e oltre, anziché ispirarsi alla natura, si rifacevano alle opere dei grandi maestri come Michelangelo, Leonardo e Raffaello, cadendo così assai spesso nell’imitazione, ora sgangherata ora bizzarra, nel decorativismo, nello scompenso tra le varie parti delle composizioni, nei colori acidi e stridenti: insomma, dato che geni non erano, in una sorta di mimetismo diciamo letterario e scombussolato. Ora, anche se per qualche artista cortigiano e mediocre tutto questo è vero (pensiamo a quanti “picassiani” ci sono stati in mezzo mondo dal primo dopoguerra in poi!), è altrettanto vero che tra i cosiddetti manieristi ci furono autentici maestri i quali, partendo proprio dalla grande lezione della Cappella Sistina, arrivano a risultati eccellenti: e per noi oggi forse più inquietanti e affascinanti, dato che viviamo in un periodo di crisi, dei capolavori dei maestri qui ricordati.
Manierismo, dunque, è un termine derivato dal Vasari, il quale nella terza parte delle “Vite” usò espressioni come: “maniera secca“, “gran maniera“, per indicare lo “stile” grazie al quale Michelangelo, Raffaello, Correggio e Tiziano riuscivano a “ritrarre le cose più belle, e di quel più bello o mani o teste o corpi o gambe, aggiungerle insieme e fare una figura di tutte quelle bellezze che più si poteva“.
E questo lo fece specialmente Michelangelo, il quale “supera e vince non solamente tutti costoro che hanno quasi già vinto la natura, ma quelli stessi famosissimi antichi, che sì lodatamene fuor d’ogni dubbio la superarono, ed unico si trionfa di quegli, di questi e di lei“.
Poi per circa un secolo di simili geni non ci fu nemmeno l’ombra, perciò la pittura, e in parte anche la scultura e l’architettura, si scatenò in quadri e quadroni in cui trionfavano il gigantismo, l’allegoria, le architetture strepitose: in cui i corpi erano immensi, i colli lunghi, le teste piccole, in cui i colori (arancioni vivi, gialli e azzurri stridenti, malva e grigio pallido) si mescolavano a luci artificiali; in cui i soggetti sacri erano quasi medioevalmente straziati: il tutto fino ai grandi interventi innovatori ed equilibratori di Caravaggio e dei Carracci, nonché dei fasti eleganti e fantasiosi del Barocco.
“Maniera“, dunque, ma anche febbre di ricerca e volontà di esaltazione che nascevano non già da una problematica e da una cultura umanistico-rinascimentale, bensì da una gran “pratica”, cioè mestiere e, diremmo oggi, da nevrosi di vario genere.
Il discorso è, come si può capire, quanto mai complesso: anche perché dovremmo rievocare molti eventi storici, religiosi e sociali (dalla guerra tra Francia e Spagna, che fu deleteria per l’Italia, alla Riforma e al Concilio di Trento, ai nuovi metodi di governo delle monarchie e dei granducati) che molto contribuirono all’affermazione dell’arte manieristica; ci limiteremo perciò a ricordare che gli storici hanno diviso la ribollente “avventura” di questo tipo d’espressione in tre periodi, e cioè: il primo, che va 1515 al 1540, in cui il Manierismo appare in Italia con formule diverse; il secondo, dal 1540 al 1570, in cui le prime ricerche italiane si diffondono in Francia, nelle Fiandre e nei Paesi Bassi; il terzo, 1570–1610, che vede l’affermazione del Mamerismo in tutta l’Europa, mentre in Italia si sviluppa il naturalismo classico.
Tuttavia, dopo queste pur utili indicazioni, il modo migliore per capire le qualità e gli eventuali limiti del manierismo è ricordare alcuni dei suoi protagonisti; i più grandi dei quali curiosamente e stranamente, come avverrà poi per colui che tutti li supererà, e cioè Caravaggio, ebbero esistenze “scapigliate”, o “maledette”, per ricorrere a termini venuti di moda tre secoli più tardi. Probabilmente il più grande di tutti i manieristi fu Jacopo Carucci detto il Pontormo (Pontorme, Empoli 1494–Firenze 1556), del quale Michelangelo, che aveva vent’anni più di lui, vedendo alcune opere disse: «Questo giovane sarà anche tale, per quanto si vede, che se vive e seguita, porrà quest’arte in cielo».
Questa profezia non si avverò forse del tutto; però opere quali la “Deposizione“, “Cosimo il Vecchio de ‘Medici“, la “Visitazione“, l’ “Annunciazione“, l”`Alabardiere“, sono certamente tra i capolavori di tutti i tempi.
Dopo aver studiato con Leonardo, Andrea del Sarto e altri, e avere ottenuto buoni successi, il Pontormo cominciò ad incupirsi, vivendo solo in una strana casa tra S. Lorenzo e l’Annunziata, a Firenze. Lavorava e dormiva in un soppalco sul quale saliva con una scala che poi tirava su, affinché nessuno vedesse quello che faceva e sperimentava; e raramente rispondeva a chi lo chiamava.
Maniaco in tutto e specie riguardo al cibo (come documenta il suo allucinante “Diario”), ossessionato dall’idea della morte, lavorò per oltre dieci anni ai dipinti del coro di S. Lorenzo, che non finì avendo passato il suo tempo “cancellando, leccando; disfacendo, rileccando“. Il tormentato e “michelangiolesco” lavoro venne completato dal suo amico Bronzino, e in seguito distrutto.
Altro grande fu Giovanni Battista di Jacopo detto il Rosso Fiorentino (Firenze 1495–Fontainebleau 1540), che secondo il Vasari sarebbe morto suicida. Quanto il suo amico Pontormo se ne stette chiuso a Firenze, tanto Rosso girò per l’Italia (Roma, Sansepolcro, Arezzo, Venezia); e partì poi per la Francia, dove arrivò nell’ottobre del 1530. Nominato pittore ufficiale di re Francesco I, decorò assieme al Primaticcio, il padiglione di Pomona alla corte di Fontainebleau; quindi lavorò per tre anni alla Galleria di Francesco I, eseguendo anche disegni per argenterie, mascherate e feste. Grazie ai suoi viaggi e contatti, Rosso (che, come già Pontormo, risentì per un periodo l’influenza di Dürer) fu dunque un manierista europeo, animato spesso da una sensibilità spirituale e da una fantasia spiritata, con effetti di grande efficacia come nella “Deposizione” di Volterra, nelle “Figlie di Ietro” degli Uffizi e in altre opere, molte delle quali si trovano in musei stranieri.
E per completare la tema dei manieristi “maledetti”, ecco Francesco Mazzola detto il Parmigianino (Parma 1503 – Casalmaggiore, Cremona 1540). Precocissimo, allievo del Coreggio, a 21 anni andò a Roma, dove ammirò Michelangelo e Raffaello e partecipò alle discussioni che si tennero presso Paolo Valdambrini, segretario di papa Clemente VII, assieme al Rosso Fiorentino, e Pierin del Vaga e a Giulio Romano, anch’essi luminari del Manierismo.
Tornato a Parma, nevrotico ed irrequieto, anziché lavorare si dedicò alla magia, alla negromanzia e all’alchimia. Arrestato per debiti, riuscì a fuggire a Casalmaggiore, dove morì a soli 37 anni. Protagonista di una pittura elegante e sensuale, il Parmigianino influenzò notevolmente la pittura francese attraverso gli allievi Primaticcio e Niccolò dell’Abate, che lavorarono a Fontainebleau. Fu una lezione indiretta ma profonda, generata da capolavori quali la “Madonna dal collo lungo” (Firenze, Uffizi), la “Madonna della rosa” (Dresda) e altri ancora, spesso memorabili.
Certo, dovremmo ricordare molti altri manieristi eccellenti, come il Beccafumi, il Vasari, Jacopino del Conte, Daniele da Volterra, Taddeo e Federico Zuccaro e altri ancora, assieme a diversi architetti, scultori e incisori anche stranieri: ma ci sembra che questi tre che abbiamo ricordato più a lungo, “sbandati e travagliati”, come li definì Emilio Cecchi, sintetizzino assai chiaramente ed efficacemente, oltreché autorevolmente, un periodo complesso e spesso frainteso; e che insieme confermino quanto scriveva lo storico e critico d’arte Arnold Hauser, e cioè che «il Manierismo è la prima corrente moderna: la prima che sia legata a un problema di cultura, e per la quale il rapporto fra tradizione e innovazione si ponga come un compito da essere realizzato con mezzi razionali. Non si intende il Manierismo se non si capisce che la sua imitazione dei modelli classici è una fuga dinanzi alla minaccia del caos; e che l’acuito soggettivismo delle sue forme esprime il timore che la forma possa fallire di fronte alla vita, l’arte esaurirsi in bellezza senz’anima».