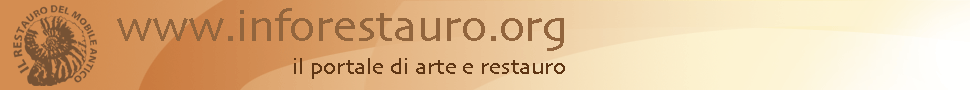I grandi mobilieri del Settecento
Nel Settecento in Italia sono molti gli ebanisti con nomi di origine straniera, ma non mancano le opere dovute ad artisti italiani che oggi sono considerate autentici capolavori:
Fonte: Alessandra Doratti
Nel Settecento in Italia sono molti gli ebanisti con nomi di origine straniera, ma non mancano le opere dovute ad artisti italiani che oggi sono considerate autentici capolavori: intagliatori di perizia straordinaria sono al lavoro in tutta la penisola.
Se si può trarre diletto e forse una qualche istruzione nel parlare di stili, di forme e di concetti artistici, non dovrebbe essere mai lecito dimenticare che le opere d’arte in genere, e i mobili in particolare, sono innanzitutto oggetti, cose fisiche. In quanto tali, dunque, è pure necessario esaminarli: non a caso uno dei grandi ingegni dell’antichità, Giulio Cesare, diceva che l’uomo è per metà anima e per metà animale e che mai si doveva rinunciare a nessuna delle due qualità. In altri termini: il fiore della poesia si nutre dell’humus della prosa. Come sono fatti, dunque, quali sono le tecniche impiegate per la costruzione dei mobili nel Settecento?
Gli italiani non furono allora ebanisti provetti: non staremo qui a chiederci i motivi di questo dato di fatto dovuto probabilmente ad una incapacità mediterranea per la meticolosa attenzione artigianale, indispensabile a questo genere di fatica. Per ebanista infatti si intende chi fa lavori in ebano, o anche in altro legno prezioso, per mobili di pregio, il che implica la sistemazione, su una carcassa di legno comune, di impiallacciature e talvolta di intarsi in rare essenze.
I rivestimenti dei più fastosi ambienti pubblici
Pazienza e accuratezza, quindi, che però non sono sempre state estranee alla tradizione italiana: uno dei titoli di gloria dell’arte rinascimentale sono le mirabili tarsie che ornano i cori di cattedrali o di cappelle di grandi famiglie, gli studioli privati di famosi personaggi come il duca d’Urbino, le porte o i rivestimenti di fastosi ambienti pubblici come le sale di Palazzo Vecchio a Firenze o le Logge di Raffaello a Roma.
Ma col passare del ‘500 la tarsia si fa via via più rara a misura che un nuovo senso architettonico sembra imporre regole alla mobilia, un senso architettonico in cui alla tarsia (essenzialmente pittorica) è consentito soltanto un ruolo marginale. Per quegli edifici in miniatura che sono gli stipi è davvero più consona una superficie perfettamente lucida sulla quale spiccheranno abbellimenti in altri materiali.
Che gli italiani non siano quasi mai grandi ebanisti (ma ci saranno luminose eccezioni) non implica che nell’intera penisola non si facessero lavori di quel genere di eccelsa qualità, anche se per lo più erano dovuti ad artefici nordici come il tedesco Giacomo Herman, attivo nella Roma dei Papi barocchi, o il fiammingo Leonardo van der Vinne, capo di una delle botteghe appartenute al granduca di Toscana. Anche nel ‘700 i nomi di origine straniera sono i più frequenti: ancora un Ermans Giovanni, lavora per il cardinale Chigi a Roma; certi Henzler alla corte di Carlo di Borbone. Ma accanto a questi forestieri si hanno notizie precise di diversi italiani: Andrea Mimmi è fornitore dello stesso porporato di cui sopra, i Magnolfi sono colleghi degli Henzler a Firenze e Gaspare Donnini, fiorentino, è il principale ebanista di Carlo III a Napoli.
Di altri nulla sappiamo: nomi senza opere, opere senza nomi. Monsieur de Lalande, che fu in Italia tra il 1765 e il 1766 scrisse sei volumetti accattivanti sul suo lungo periplo, rammenta: “di tutte le arti meccaniche quella in cui i genovesi si sono maggiormente distinti è l’ebanisteria: fanno infatti in questo campo delle opere assai delicate, molto solide e del miglior gusto”. Però nessun ebanista genovese sarà da lui menzionato. E lo stesso destino tocca a quello che è il maggior artefice italiano del secolo nel campo delle arti meccaniche, Pietro Piffetti.
Monsieur Lalande e il Piffetti definito “mediocre”
Quando Lalande visita il palazzo reale di Torino, eccolo attraversare “una piccola stanza in forma di oratorio, rivestita di legni odorosissimi con intarsi di madreperla graffita. La disposizione generale di queste incrostazioni è bella, ma le figure e gli arabeschi sono incisi mediocremente“. Non menziona l’autore di queste “mediocrità”, il Piffetti appunto, che era ancora in attività.
All’ebanisteria occorrono non solo legni esotici ma anche altri materiali più peregrini. L’avorio, ad esempio, ottiene severi ma eleganti contrasti se accostato all’ebano. Un tipo particolarmente sofisticato di ebanisteria, così prezioso da sconfinare nel lavoro di oreficeria, è quello dei tartarugari napoletani che rivestono piccoli mobili di sottili lastre di tartaruga incisa e graffita d’oro, avorio e madreperla (la stessa tecnica adoperata anche per cofanetti, pettini e piccoli oggetti).
Il mobile di ebanisteria (comò, stipi, scrivanie, tavoli, rarissimamente sedie) si completa sovente di supporti, guaine, applicazioni o veri e propri abbellimenti in bronzo dorato; qualche volta, soprattutto a Napoli e a Palermo vi sono anche incastonature di ottone, a mo’ di semplici gigli che delimitano le sagome e proteggono la serratura. Nei mobili di destinazione aulica queste rifiniture diventano capolavori della piccola plastica per alcuni dei quali sappiano i nomi degli autori. A Firenze, lo scultore Giovanni Battista Foggini è responsabile, tra Sei e Settecento, del disegno e dell’esecuzione di queste squisitezze e, più tardi, in epoca rococò, altri artisti meno noti come Romolo Bini eseguono bronzetti di questo tipo.
Il marchese estasiato nelle botteghe del granduca
I mobili d’intaglio hanno sempre raggiunto eccelsi vertici qualitativi in Italia. Già nel 1670 un figlio del famoso ministro di Luigi XVI, Colbert, il marchese di Seigneley, si era estasiato durante la sua visita a Firenze, nelle botteghe del granduca e si era soffermato ad ammirare una corona di fiori intagliata “così bene eseguita che le foglie non sembravano più spesse di quelle naturali“. Oggi non ci sono noti questi intagli, ma se si osservano le cornici attorno ad alcuni dipinti di Palazzo Pitti si riscontrerà una straordinaria perizia artigianale.
Intagliatori superbi furono all’opera non solo a Firenze ma un po’ ovunque in Italia: a Venezia, a Genova, a Roma e nello stesso Stato della Chiesa. I mobili di tipo scultoreo sono, salvo qualche gloriosa eccezione come quelli di Andrea Brustolon, in legni teneri o dolci e dunque debbono essere dipinti, laccati o dorati per raggiungere l’effetto ornamentale desiderato.
Questi procedimenti cambiano, come ogni cosa nella penisola, di capitale in capitale: nel Meridione, ad esempio, c’è un particolare tipo di doratura detto a mecca e che consiste nello stendere una vernice dorata sulla superficie argentata in modo da ottenere qualche risparmio; tuttavia nei mobili di corte il procedimento resta sempre quello più costoso, per cui si utilizza la foglia d’oro. La lacca di origine orientale ma adoperata a Venezia già nel Rinascimento godette grande successo in tutta l’Europa, dall’Inghilterra, alla Spagna, ai Paesi germanici. In Italia il suo impiego cambia di città in città anche se fino a pochi decenni fa si riteneva che ogni opera di pregio dovesse essere necessariamente veneziana. I luoghi comuni hanno sempre una ragion d’essere: gli esempi veneziani del ‘700 raggiungono infatti un livello qualitativo notevole dovuto alla meticolosa attenzione con cui gli artigiani stendevano, mano dopo mano, l’amatissima vernice su una superficie dipinta e scrupolosamente levigata.
Quei genovesi, parsimoniosi anche con la lacca…
Nei mobili laccati genovesi, invece, la decorazione dipinta è spesso più sommaria e la lacca è data con fin troppa parsimonia; a Roma si utilizzano spesso ornati a bassorilievo e i contrasti cromatici sono piuttosto vivaci. Una soluzione decorativa molto originale fu adoperata solo a Venezia: essa accostava la lacca a motivi sia orientali sia occidentali con generose incastonature di madreperla. Questa felice combinazione è rara persino in Oriente ma se ne conoscono esempi sia cinesi sia giapponesi che dovettero essere noti in qualche modo alla città. Nella stessa Venezia viene sovente adoperata la cosiddetta lacca povera, tecnica meno costosa e raffinata che tenta di imitare – tramite l’applicazione di figure e paesaggi stampati su carta, ritagliati, coloriti e ricoperti di una vernice brillante – i più nobili ornati sopra descritti.