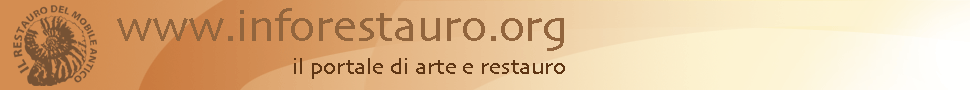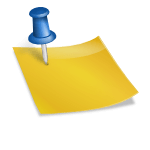La Madonnina del Grappa e le fasi del restauro
Gli enunciati di Cesare Brandi hanno costituito la linea guida per il restauro di questa Opera nel rispetto della sua unicità artistica restituendola alla sua funzione di culto.
A cura di Ezio Flammia
Il valore del restauro secondo Cesare Brandi
Focus: Presentazione delle teorie di Cesare Brandi sul restauro, sottolineando l’importanza di preservare l’autenticità estetica e storica dell’opera d’arte.
Cesare Brandi direttore dell’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) dal 1939 al 1959, nella sua “Teoria del restauro, scriveva:
“Il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro.” Egli, concludendo il capitolo sul concetto di restauro, affermava inoltre: “Il restauro deve mirare al ristabilimento della sua unità potenziale dell’opera d’arte, purché ciò sia possibile senza commettere un falso artistico o un falso storico, senza cancellare ogni traccia del passaggio dell’opera d’arte nel tempo.“
Questi enunciati, dettati da uno dei massimi intellettuali che vantava l’Italia e ispiratore della teoria del restauro conservativo, di fama internazionale, maestro tra l’altro, d’illustri storici dell’arte quali Claudio Strinati, sono i valori ai quali da sempre mi sono attenuto sin da quando ho iniziato a restaurare le opere che mi venivano affidate.
Descrizione della scultura: La Madonnina del Grappa
Focus: Analisi della composizione e struttura della scultura, con un focus sulla combinazione di materiali come la cartapesta e il legno, e sul valore simbolico dell’opera.
Con gli stessi principi esposti e finalità ho lavorato al recupero per una buona fruibilità della Madonnina del Grappa, sia in vista della sua trasmissione al futuro e sia per la sua funzione di opera di venerazione come “offerta a Maria”.
L’opera nella sua manifesta semplicità è, viceversa, una scultura complessa e ben strutturata come tutte le opere di valore. La scultura, non molto grande, con un peso eccessivo per un’opera di cartapesta, come a tutti appare, è in realtà una scultura concepita con due essenze d’arte.
Luigi Guacci, grande maestro, l’ha realizzata utilizzando la cartapesta e il legno. Questo l’ho scoperto solo durante il lavoro, quindi, ho potuto appurare che molti elementi che compongono la scultura sono stati scolpiti nel legno di noce quali: la testa e gran parte del corpo del serpente-diavolo, i piedi e la testa della Madonnina, in parte il corpo del Bambino.
La Madonnina del Grappa è, perciò, un’opera composita con cui Luigi Guacci ha dato un saggio della sua abilità esecutiva in grado di abbinare le materie «poco nobili», conseguendo effetti mimetici sorprendenti e rendendo la scultura appropriata alle esigenze di venerazione al pari di un simulacro in materiale nobile.
Questo è la riprova della duttilità della cartapesta che alla ben nota singolarità di tecnica polimaterica composta di carta, colla, gesso colori e vernici, si armonizza con qualsiasi materiale e può imitare persino altre forme d’arte. Nel nostro specifico riproduce il metallo sino ad apparire come se fosse di vero bronzo.
Interventi preliminari: Stabilizzazione della base
Focus: Lavori iniziali per rafforzare e stabilizzare la base della scultura, descrivendo i dettagli tecnici del rinforzo e delle sostituzioni effettuate.
Nelle precedenti pubblicazioni di questo restauro ho messo in luce lo stato di decadimento dell’opera castiglionese soffermandomi sulle diverse parti maggiormente deteriorate.
Una di queste era la base di legno su cui è stata costruita la Madonnina del Grappa. Questo sostegno, realizzato come una piccola pedana di forma quadrata con gli angoli smussati, aveva le parti a contatto con il pavimento tarlate e deboli che compromettevano la stabilità della scultura. Per questo è stato necessario iniziare il lavoro di recupero risanando la base per proseguire il restauro in assoluta sicurezza.
Sono state eliminate e sostituite e distinte con colore grigio due angoliere all’interno della pedana poiché tarlate e inutilizzabili. Vedi Fig.1 Cinque lati della pedana interna (3 lati lunghi e due angoli smussati), sono stati rinforzati con listelli di legno “ramino” stagionato incollati agli stessi sotto pressione con morsetti. Vedi Fig. 2


Per una migliore consistenza della pedana sono state stuccate le unioni dei legni e ricostruite le parti mancanti con colla e polvere di segatura. Per una migliore stabilità e isolamento della pedana dal pavimento, su tutto il suo perimetro è stata aggiunta una striscia di feltro (marrone) Vedi Fig.3

Consolidamento della cartapesta e della pellicola pittorica
Focus: Dettaglio del complesso processo di consolidamento delle componenti cartacee e pittoriche, con particolare attenzione al trattamento delle crettature.
Questo è stato il lavoro più impegnativo che ha richiesto molti e ripetuti interventi.
Per come si presentava la materia cartacea ovvero la cartapesta di cui si compone la scultura, escluse le parti in legno, appariva debole e non più nelle condizioni di fare da supporto alla pellicola cromatica. L’imprimitura a gesso e colla era degradata e in parte rialzata in spesse craquelure leggere e profonde, piccole e grandi, soprattutto nella parte retrostante della scultura. Vedi Fig. 4 e Fig. 5


Per rinvigorire il manufatto di cartapesta e per riattaccare le craquelure di colore si è reso necessario dividere la superficie scultorea in piccole zone sulle quali intervenire gradualmente senza lasciare incontrollato il ben minimo spazio.
Ad iniziare dalla zona comprendente metà del cranio della Madonna si è deciso d’intervenire ricoprendo l’area interessata di pasta di frumento per la durata di almeno un’ora cercando di farla penetrare nelle parti sollevate e nelle fessure, maggiormente su quelle isole di crettature che si erano sollevate a scodella. Vedi Fig. 6.

Durante queste operazioni che, come è stato detto, sono state ripetute più volte sino ad ammorbidire le spesse isole di crettature, parti della pasta di frumento penetrando nella materia cartacea attraverso le fessure hanno irrobustito la materia cartacea della scultura.
Nella parte finale di queste operazioni, quando le crettature sollevate si stavano adagiando nella loro sede d’origine, si è fatto penetrare, sempre tra le fessure, la colla di pesce molto diluita (colletta) in modo da stabilizzare ancor di più la cartapesta.
Infine, quando tutte le varie isole delle crettature sono state incollate, si è fatto penetrare ulteriormente nelle stesse fessure della colla di primal a più riprese ad iniziare dalla soluzione acquosa a quella più consistente.
Dopo tutti questi continui e prolungati interventi, l’intero manufatto ha interamente ripreso la sua antica consistenza materica, per cui, si è provveduto a stuccare le fessure e le lacune con gesso di Bologna e colla di coniglio, alcune documentate nelle precedenti pubblicazioni.
Pulitura generale del film pittorico
L’intera superficie della scultura, dopo il fissaggio delle isole di crettatura è stata ulteriormente pulita del rimanente sporco, di macchie di grasso e degli schizzi persistenti di colore bianco lavabile ancora giacenti sul film pittorico.
Ricostruzione delle parti mancanti
Focus: Procedura utilizzata per ricreare elementi mancanti come dita, scettro e dettagli della corona, garantendo stabilità e coerenza estetica.
Tutte le parti mancanti sono state ricostruite con la cartapesta e alcune, per una migliore stabilità, sono state modellate su sostegni di fil di ferro. Le parti ricostruite sono: il mignolo e il pollice della mano destra della Madonnina del Grappa, tre dita della mano destra e il piede del Bambino, lo scettro, la coda e la lingua (quelle terminali) del serpente-diavolo, il labbro inferiore della bocca della Madonnina, due elementi della corona. Fig. 7, Fig. 8 e Fig. 9



La mano con scettro della Madonnina del Grappa ha rivelato un sorprendente sistema ideato per salvare questo specifico particolare che, per come è stato costruito, risultava alquanto precario per cui si sarebbe distrutto con facilità persino durante il trasporto. Non a caso, lo scettro, è l’unico elemento che non si è conservato.
Il geniale autore della scultura, per ovviare a questo inconveniente, progettò e costruì la mano con lo scettro su un quadrello di legno sporgente di circa 6 centimetri dal polso. Inserendo la sporgenza del legno con la mano e lo scettro in un apposito vano all’interno della scultura, realizzato all’altezza del gomito, l‘arto reggente con il simbolo regale appare un tutt’uno con la scultura. Vedi Fig.10 e Fig. 11


Inoltre, ideò la mano con due fori uno tra il pollice e l’indice e l’altro alla fine dell’indice all’altezza dell’unghia. Inserendo e fissando tra i fori e lo scettro due piccoli tondini di legno, l’oggetto regale sembra che sia retto con armonia dalla mano della Madonnina. Vedi Fig. 12, Fig. 13 e Fig.14



Ritocco pittorico
Focus: Descrizione del lavoro di ritocco con colori a olio per reintegrare le parti restaurate e mantenere l’armonia cromatica originale.
Poiché l’intero manufatto è stato colorato a cera si è reso necessario utilizzare i colori ad olio. Le lacune e le altre parti stuccate come i solchi delle crettature e gli elementi ricostruiti sono stati dipinti con colori ad olio e con vernice per ritocco. Tutti questi prodotti sono della Lefranc Bourgeois.
Nella prossima e ultima pubblicazione su questo restauro si riporteranno le conclusioni finali e le immagini della Madonnina restituita alla sua funzione di culto e soprattutto reintegrata nel suo singolare splendore.
Gli altri articoli relativi al Restauro della Madonnina del Grappa
- La Madonnina del Grappa e le fasi del restauro
- Il Restauro della Madonnina del Grappa: seconda parte
- Restauro conservativo della “Madonnina del Grappa”