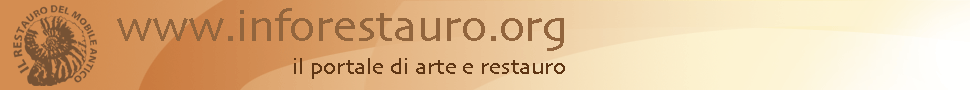La scagliola: storia tecnica e restauro
Storia, tecnica e restauro della scagliola. Una antica tecnica decorativa che ha tentato di imitare in modo economico l’uso del marmo e del “commesso”
L’ arte della scagliola: dove, come, quando nasce
Focus: La tecnica della scagliola nasce nel tardo Rinascimento e si sviluppa nel Barocco, con Guido Fassi come uno dei primi inventori documentati.
Il passaggio dal tardo rinascimento al barocco avviene gradualmente a partire dalla fine del cinquecento, per essere compiuto pienamente nella seconda metà del seicento.
Tra le più importanti caratteristiche dello stile che si viene affermando c è la ricerca di forme sempre più mosse e dinamiche.
Il periodo culturale della Controriforma – il Concilio di Trento inizia nel 1545 – porta, insieme alla riforma religiosa in senso stretto, innovazioni in ogni espressione dell’arte sacra. Sulla linea della riaffermazione del primato della Chiesa romana, è infusa una nuova solennità alle opere d arte: ora si ricerca la monumentalità, il gusto scenografico e ricco.
Anche se si cominciano a costruire nuove chiese a partire dai grandi centri, le zone periferiche non rimangono a lungo indifferenti, anzi spesso rispondono al richiamo dell’innovazione con un fiorire di espressioni locali. Le novità non si limitano ai beni ecclesiali ma i canoni artistici nati nella Controriforma vengono assimilati anche dall’arte “profana”; e questo è facile da capire se si pensa a quanto la Chiesa fosse centro di potere politico e indirizzo culturale, al di là del dato religioso.
Nel museo civico di Carpi è conservato il ritratto di Guido Fassi all’età di trentadue anni, sul quale vi si legge la scritta “Guido Fassi da Carpi inventore dei lavori in Scagliola colorita e macchinista 1616“. Anche se non si può attribuire con certezza la paternità al Fassi, questa è la prima testimonianza documentabile dove si specifica l’invenzione della tecnica.
Guido Fassi (1584-1649): di lui sappiamo che era un artista poliedrico, attivo nel campo dei progetti edili, dell’ingegneria, idraulica, meccanica, e tutte le attività che richiedevano una dimestichezza con il materiale edilizio (in particolare lo stucco).
Ci sono rimaste testimonianze del lavoro in scagliola del Fassi, in particolare alcune ancone, dalle quali possiamo dedurre come in questo periodo la tecnica sia ancora legata all’imitazione del marmo (quindi è ancora un surrogato di materiali troppo costosi) e usata con una plasticità che fa riferimento in modo particolare all’architettura.
L’unico precedente nell’uso di questa tecnica è di alcune maestranze locali di Austria e Germania. In particolare gli esempi più precoci sono quelli bavaresi: è documentata, purtroppo solo “sulla carta”, nel 1591 l’attività di uno stuccatore, che eseguiva piani di tavolo decorati con stucchi colorati.
Inoltre nella Residenza di Monaco sono presenti innumerevoli esempi dell’uso di scagliola con funzione decorativa, realizzati dalla famiglia Pfeiffer, dal 1607 al 1612. I disegni e l’apparato decorativo sono ispirati e talvolta imitazione di quelli fiorentini in commesso di pietre dure.
E’ difficile supporre una influenza reciproca tra il Fassi e la famiglia Pfeiffer, considerata la quasi contemporaneità delle loro attività; gli ultimi studi (A.Garuti, La scagliola: arte dell’artificio o della meraviglia, 1990) tendono a preferire l’ipotesi di un percorso analogo compiuto, in Baviera poco prima che a Carpi, sulla base comune della sperimentazione.
Fassi ci ha lasciato due esempi di imitazione marmorea molto raffinati.
I paliotti dei due altari sono stati realizzati da Giovanni Gavignani circa un trentennio dopo.
Diffusione della scagliola
Focus: La scagliola si diffonde rapidamente in Emilia Romagna e nel Nord Italia, con importanti centri di produzione come la val d’ Intelvi.
Dalla zona di nascita, a Carpi, in pochi decenni la scagliola si diffuse in Emilia Romagna e nel Nord Italia, facilitata dai frequenti spostamenti delle maestranze specializzate in campo edile. Un polo di produzione delle scagliole divenne la val d’ Intelvi, vicino al lago di Como. Presso la parrocchia di S.Stefano a Gottro sono conservate le prime opere in scagliola documentate del Nord Italia, realizzate nel 1664 da don Carlo Belleni.
A Napoli, maestranze locali ci hanno lasciato importanti testimonianze nei paliotti dell’abbazia di Padula (fine XVII sec.).
L’ uso diffuso della scagliola in alcuni centri periferici all’inizio del secolo XVII, è da attribuirsi alla facile reperibilità delle materie prime, al loro basso costo e alla facilità di lavorazione. Quasi da subito però quest’arte minore si presta a piccole, isolate, manifestazioni di stravaganza e a più azzardate sperimentazioni rispetto all’arte maggiore della lavorazione marmorea.
Parallelamente alla grande produzione sacra, soprattutto di paliotti e di ancone d altare, si sviluppa l’uso della tecnica applicata a mobili e manufatti d uso “domestico” di rappresentanza; ciò avviene spesso per mano dei medesimi artisti. Attraverso alcuni grandi scagliolisti carpigiani è possibile ricostruire una piccola storia del percorso artistico che giunge fino alla metà del XVIII secolo.
Gli Artisti
La scuola carpigiana segue due filoni stilistici, nati da due allievi del Fassi: ANNIBALE GRIFFONI (1619-1679) e GIOVANNI GAVIGNANI (1615/1632-1680).
Griffoni è il più legato ai caratteri locale dell’arte, sebbene abbia lavorato anche fuori dai confini di Carpi e Modena; dalla sua scuola escono il figlio GASPARE GRIFFONI (1640-1698), GIOVANNI LEONI (1639-1710), GIOVANNI POZZUOLI (1646-1734), GIOVANNI MASSA (1659-1741).
Gavignani è artista di estrema perfezione formale, nella ripresa dei disegni rinascimentali in un severo bicromatismo; sono suoi discepoli SIMONE SETTI (notizie tra il 1659 e il 1688) e GIOVAN MARCO BARZELLI (1637-1693).
Giovanni Leoni
A questo artista dobbiamo la diffusione della tecnica della scagliola ad intarsio nel cremonese e a Milano.
Delle opere della scuola carpigiana ci rimangono soprattutto quelle di destinazione ecclesiale; non è così per il Leoni del quale abbiamo alcuni esemplari notevolissimi di arredi di destinazione laica. La sua eccelsa imitazione dei piani di tavolo a commesso di pietre dure ha segnato una punta altissima nella storia di quest’arte, pur andando a discapito dell’autonomia che a fatica si è andata conquistando.
Una coppia di stipi di attribuzione certa, firmati e datati “Gio. Leone F. 1680-81”, decorati a scagliola policroma, in eccezionale stato di conservazione.
Gli stipi di dimensioni: 129 X 145 X 39 cm., sono conservati al castello di Konopiste (Cecoslovacchia), provenienti dal palazzo ducale di Mantova. A Konopiste si conserva una buona parte dei beni appartenuti agli Estensi.
Coppia di piani di tavolo, conservata nella rocca di Fontanellato (Parma), 1680-1690. Negli ovali sono rappresentate due scene delle fatiche di Ercole.
Piani per una coppia di console inizi del XVIII secolo.
Mentre nel primo il decoro è di gusto naturalistico (paesaggio al centro e cestini di fiori ai lati) nel secondo c è un motivo a trompe l’oeil con carte da gioco e portafiches; sono proprio i tavolini da gioco ad accogliere la maggior parte dei piani in scagliola e ad interessare i viaggiatori soprattutto inglesi al tempo del “grand tour”.
POZZUOLI e MASSA sono gli autori dell’altare maggiore di S.Ignazio a Carpi, nel 1696.
Quest’opera è significativa per la ricerca naturalistica e l’effetto pittorico tipici della cultura carpigiana, particolarmente sviluppata da questi due artisti.
GAVIGNANI, capostipite del filone stilistico più rigoroso, più “compassatamente rinascimentale”, è l’autore di questo quadretto, capolavoro e manifesto dell’autonomia della tecnica della scagliola, libera dal ruolo di “marmo povero”.
La chiesa di S.Niccolò a Carpi ospita due paliotti di raffinata lavorazione, con un virtuosismo nel disegno, classicheggiante, che solo Gavignani ha posseduto.
SIMONE SETTI, lavora esclusivamente in bianco e nero; di lui ci rimane un vasto repertorio di piani di tavolo; nota comune di tutti è l’armonica impostazione classica, “disturbata” solo talvolta dalla ricchezza decorativa barocca.
Dopo un lungo periodo di crisi, in cui la scagliola è relegata a procedimento artigianale, si incontra un breve periodo di rinascita nell’ottocento, in cui la tecnica viene legata molto alle tecniche di stampa monocroma.
La tecnica
Focus: La scagliola si ottiene dalla selenite e viene lavorata con pigmenti naturali. La lavorazione richiede circa tre mesi.
La scagliola si ottiene dalla selenite (solfato di calcio biidratato) un minerale che in natura si presenta con una caratteristica struttura a scaglie. I pezzi di selenite sono estratti dalle cave (l’Appennino Emiliano, la Lombardia e la Calabria ne sono ricchi) e posti in forno dove alla temperatura di 128°C si disidrata e polverizza.
In seguito la polvere è pestata in un mortaio per polverizzarla completamente, e dopo averla ben setacciata da ogni impurità si ha la polvere bianca detta scagliola. Questa polvere rimescolata all’acqua, tende a ricomporre la sua struttura molecolare originaria, ma il gesso che si ottiene è fragile e tenero.
Verrà quindi mescolata a colle, solitamente colla madre molto diluita, chiamata acqua di colla.
Sulla scelta dei pigmenti per colorare la scagliola gli artisti hanno potuto godere dell’esperienza acquisita nel campo degli affreschi che ha fornito preziose informazioni riguardo la compatibilità con i gessi. Si tratta di tutte le terre naturali e bruciate, dei derivati dell’ossido di ferro e di alcune lacche di origine vegetale (garanza, gialla, viola porporina). Particolare rilievo i neri che sono spesso stati l’unico pigmento, nelle opere monocrome: nero fumo, caldo e intenso; nero di vite, leggermente trasparente; nero avorio, grigiastro e freddo.
La lavorazione avviene su un piano ligneo, si tratti della realizzazione di un piano di tavolo o di un paliotto, dove viene gettato il letto di scagliola per accogliere l’armatura. Questa è prevalentemente fatta di canne palustri, ma ci sono esemplari con armatura lignea o addirittura di cocci di mattone; su di essa si posa la seconda gettata, la coperta.
Perché tutto sia asciutto e pronto da staccare dalla base lignea occorrrono dai 15 ai 20 giorni. Solo a questo punto viene realizzato il disegno, in genere con l’aiuto dello spolvero del disegno preparatorio. Gli scavi, profondi per il disegno e superficiali per il chiaroscuro, sono fatti con sgorbie a “V”, “C” e “U”. In seguito avviene il riempimento delle incisioni con paste colorate o monocrome.
L’ultima sequenza è quella della levigatura, con carbon dolce di faggio o salice, e lucidatura a base di olio di oliva e di noce. La lucidatura è molto insistente ed accurata proprio per proteggere il manufatto altrimenti troppo sensibile all’umidità, per garantire insomma buone proprietà di resistenza e impermeabilità.
La lavorazione, secondo questi procedimenti, di un paliotto di medie dimensioni o di un piano da tavolo medio-grande dura circa tre mesi.
Sezione del supporto, armatura in canne palustri e riproduzione di un cartone preparatorio, forato per eseguire lo spolvero
Problemi di conservazione e restauro
Focus: La scagliola è sensibile all’umidità e il restauro è complesso, spesso limitato a interventi estetici riconoscibili dall’originale.
Il degrado delle opere in scagliola è principalmente dovuto alla porosità dell’impasto, che subisce in modo sensibile gli sbalzi di umidità.
L eccessiva umidità è causa dello sfarinamento e di altri mutamenti meno gravi ma “premonitori” di una situazione critica: striature giallastre, imbianchimento, affioramento di muffe. Se avviene un distacco dal supporto, oltre alle cause climatiche bisogna supporre un difetto di lavorazione.
Il restauro di questo tipo di manufatti è molto difficoltoso perchè -ad oggi- il deterioramento che subiscono è ancora da considerarsi irreversibile.
L unico tipo di intervento proposto è quindi quello restitutivo, integrativo delle parti che siano andate perdute, con un restauro estetico riconoscibile dall’originale.
BIBLIOGRAFIA sull’arte della scagliola
Graziano Manni, MOBILI ANTICHI IN EMILIA ROMAGNA
Poligrafico Artioli, Modena, 1980
Augusto Giuffredi, LA SCAGLIOLA RITROVATA
Comune di Montecchio Emilia, 2001
Colli, Garuti,Pelloni, LA SCAGLIOLA CARPIGIANA E L ILLUSIONE BAROCCA
Ed. Artioli, Modena, 1990
Eustachio Cabassi, NOTIZIE DEGLI ARTISTI CARPIGIANI
Ed. Panini, Modena 1986
Sito internet del MUSEO DELLA SCAGLIOLA, Comune di Carpi.