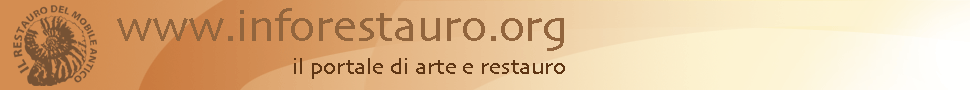Le facciate dipinte di Acqui Terme
La trasformazione d immagine delle facciate recuperate
Si è già avuto modo di spiegare come la solerzia, nel recupero delle facciate, da parte della Pubblica Amministrazione sia stata, innegabilmente, agevolata dall’invio delle Ordinanze: non a caso, oggi, a distanza di pochissimi anni, il centro storico di Acqui Terme si presenta decisamente rinnovato grazie anche alla nuova immagine delle sue facciate.
Successivamente si è anche dimostrato che, durante gli ultimi interventi, sono stati utilizzati materiali così nuovi da risultare, spesso, incompatibili coi supporti sui quali sono stati applicati, a scapito della loro stessa conservazione. Discorso, quest’ultimo, che caratterizza buona parte delle recenti operazioni condotte sui centri storici al punto che è difficile potere parlare di azioni di recupero su singoli manufatti architettonici o interi complessi urbani che non hanno portato, a posteriori, a qualche controindicazione.
Alla luce di tutte queste considerazioni c è, però, un aspetto che mi preme sottolineare: quello relativo alla passata immagine della città e a quanto di questa sia stato riproposto fedelmente nell’attuale configurazione. La questione riguarda direttamente le facciate, i decori e i colori che su queste possono essere ancora rintracciati dove non rimossi o smantellati per sempre.
Che la città sia mutata dall’Ottocento ad oggi è fuori di dubbio e le modifiche che ha subito non sono state di semplice facciata ma hanno assunto, spesso, dimensione urbanistica: come nel caso della deviazione del corso del Medrio per dar posto ad una nuova via di rappresentanza, dell’abbattimento delle mura per favorire l’assemblaggio di quelle porzioni di territorio più esterne, dell’eliminazione di buona parte delle abitazioni presenti sull’attuale Piazza Conciliazione, per risolvere in maniera più veloce l’inadeguatezza igienica di uno spazio urbano eccessivamente edificato (solo per citarne alcune).
Dalla scala urbana, gli interventi ottocenteschi si sono spostati a quella edilizia e molte vecchie cartoline sono la chiara dimostrazione di quello che c era e non c è più: alcuni edifici sono, infatti, scomparsi del tutto, altri sono stati sostituiti con nuovi, di diversa impronta stilistica, molti, infine, sono stati modificati o variati nelle dimensioni. Di questi, la maggior parte aveva facciate variamente decorate e il loro insieme architettonico è rimasto nell’immaginario collettivo, dandoci l’idea di una città che, nell’Ottocento, era piuttosto armoniosa e piacevole.
E chiaro che non sono stati certo gli ultimi interventi ad avere contribuito, in maniera assoluta, al cambiamento d immagine della città, le cui facciate, già a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento, hanno cominciato a mutare aspetto a seguito dei diversi interventi di recupero cui sono state sottoposte: a riprova il fatto che, ancora oggi, sulle poche non ancora ristrutturate sono leggibili talvolta tipi diversi di decorazione e strati sovrapposti di colori differenti. I riscontri fotografici tra passato e presente hanno permesso di scoprire, inoltre, che alcune facciate hanno subito la modifica, talora sostanziale, dell’apparato decorativo e che il loro aspetto attuale fa riferimento al decoro più recente: è il caso di alcune facciate su Piazza Bollente, Via G. Bove e di diverse su Corso Italia e Via Garibaldi.
Il criterio che ha guidato gli ultimi interventi di ristrutturazione (esplicitamente indicato nell’Ordinanza) prevede, anzitutto, lo studio preliminare dello stato di fatto al fine di possedere un adeguata conoscenza dell’edificio. Successivamente e prima della demolizione degli intonaci originari (il più delle volte cadenti ed irrecuperabili ma non sempre) è richiesto l’accurato rilievo delle decorazioni pittoriche esistenti, per poterle riprodurre fedelmente sui nuovi intonaci.
Rispetto queste premesse (circa le quali, credo, non possano essere mosse obiezioni) si tratta di verificare per quale motivo, nella realtà dei fatti, la maggior parte degli originari decori di facciata sia stata riprodotta esattamente mentre una piccola parte sia stata modificata, alterata e, persino, non realizzata. Su Corso Italia, vi sono sia casi in cui la vecchia decorazione è stata riproposta arricchita (ad esempio con l’apertura di finte persiane, originariamente chiuse o con l’inserimento di elementi aggiuntivi, al solo scopo estetico), sia casi in cui è stata riprodotta senza alterazioni. Da ultimi, gli esempi di decori che non sono stati più riproposti, pur se presenti (circa i quali non si sa se esista, in proposito, qualche specifica intenzione) o che sono stati realizzati ex-novo, per preciso volere della committenza.
Si capisce, infatti, che in tutti questi casi tanto il committente (generalmente non unico proprietario dell’edificio), quanto il direttore lavori assolvono un ruolo particolarmente importante. Il primo, dovendo pagare lui stesso l’esecuzione delle decorazioni, fa spesso esplicita richiesta di poterle semplificare e, persino, ridurre; il secondo, invitato alla minimizzazione delle spese, non trova altra via che quella di risparmiare sull’insieme delle indagini preliminari, trascurando in questo modo la possibilità di approfondire meglio la conoscenza dell’edificio.
Altra questione è poi quella delle tinte di facciata, circa le quali non vi è un esplicito rimando neppure nell’Ordinanza, se non laddove si parla di ricerche stratigrafiche da eseguirsi sugli intonaci prima della loro eventuale rimozione. E stato possibile constatare che nell’insieme degli interventi effettuati il mantenimento dei colori originari non sempre è stato rispettato: sia per questioni di ordine estetico, relative alla ricerca di una migliore intonazione cromatica al contesto urbano, che per la volontà di riproporre le tinte emerse dalle indagini stratigrafiche.
Va anche detto che, spesso, la differenza tra le tinte passate e quelle attuali deve essere imputata al limitato effetto cromatico di queste ultime le quali, facendo ricorso a pigmenti di tipo artificiale, difficilmente producono una resa simile a quella delle terre naturali. Ecco perché su molte delle facciate recuperate i nuovi colori impiegati, apparentemente simili a quelli originari, risultano, di fatto, molto più freddi, il che provoca un duplice effetto: l’eccessiva durezza della facciata e la riduzione della sua complessiva plasticità.
Le trasformazioni recenti appena descritte, possono essere lette come l’effetto di questa normativa che, se da un lato ha promosso il recupero di un centro storico gravemente ammalorato, dall’altro non è riuscita a controllare le modalità con cui questo fenomeno si stava attuando: non a caso la libertà di certe scelte progettuali è stata giustificata proprio dal fatto che oggetto di recupero fosse un intero centro storico piuttosto che un singolo monumento.
E stata, ancora una volta, l’immagine turistica della città ad avere giocato da protagonista, a svantaggio della sua, grande o piccola che sia, tradizione storica che meriterebbe, invece, d essere legittimamente salvaguardata.